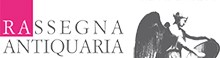Ogni edizione di “Rassegna Antiquaria” ospita una mostra collaterale che accoglie i visitatori nel foyer d’ingresso. Una sorta di “evento nell’evento” che anticipa la mostra vera e propria, allestita all’interno del padiglione centrale. Ogni anno il tema è diverso e, per analogia o talvolta per differenza, è destinato a solleticare la curiosità degli appassionati di arte.
L’edizione 2024 propone l’evento collaterale dal titolo “BLU OLTREMARE – Omar Galliani tra luce e ombra” con una selezione di opere dell’artista emiliano.
Omar Galliani ha sperimentato una particolare tecnica di utilizzo della grafite, sviluppando un approccio personale che ha estimatori in tutto il mondo. Le sue opere hanno trovato spazio in tre diverse edizioni della Biennale di Venezia (1982, 1984, 1986), nonché alle Biennali di San Paolo del Brasile (1981) e Parigi (1082), e in esposizioni a Tokyo, nei musei d’arte contemporanea di Kyoto, Nagasaki, Hiroshima, Francoforte, Berlino, Hannover e Vienna. I visitatori di “Rassegna Antiquaria” avranno la possibilità di apprezzare il suo percorso, attraverso una selezione disegni a matita realizzati su supporti di legno grezzo.
- Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS)
Tel:+39 030 961148 – Fax +39 030 9961966
- Dal 23 novembre al 1 dicembre 2024
Scopri gli orari